Introduzione
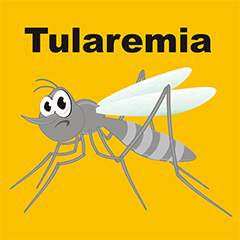
La tularemia, nota anche come “febbre dei conigli”, è una malattia febbrile causata dal batterio Francisella tularensis che può infettare numerosi animali selvatici e domestici. Si può contrarre attraverso il contatto diretto con animali infetti, con l’ingestione di acqua contaminata o di carne poco cotta proveniente da animali infetti, ma anche attraverso la puntura di diversi artropodi, come le zanzare e le zecche. Nella maggior parte dei casi, la malattia si presenta come un’ulcera localizzata nel punto di introduzione dell’agente patogeno dell’organismo, accompagnata a gonfiore dei linfonodi regionali.
Due tipi di F. tularensis causano la maggior parte dei casi di tularemia:
- tipo A, è il sierotipo più virulento per l'uomo; si ritrova generalmente nei conigli, nelle lepri e nei roditori negli Stati Uniti e in Canada
- tipo B, causa abitualmente un'infezione ulcero-ghiandolare lieve e si ritrova nei roditori e negli ambienti acquatici in tutto l'emisfero boreale, incluso il Nord America, l'Europa e l'Asia
Sintomi
L'esordio della tularemia è improvviso, i cui sintomi come cefalea, brividi, nausea, vomito, febbre da 39,5 a 40° C e stato di grave indebolimento possono verificarsi entro i primi 10 giorni dall'esposizione.
Sono descritte diverse manifestazioni cliniche che dipendono in parte dal tipo di esposizione:
- forma ulcero-ghiandolare, è la manifestazione più comune ed è caratterizzata dalla comparsa di un piccolo rilievo solido della pelle (papula) che va incontro a ulcerazione. A questa lesione della pelle si accompagna un aumento di volume delle linfoghiandole regionali che spesso vanno incontro a suppurazione
- forma ghiandolare, si presenta con aumento di volume di una o più linfoghiandole in assenza di una lesione della pelle. Si verifica più spesso nei bambini rispetto agli adulti
- polmonite, può essere primaria (dovuta alla diretta inalazione del patogeno nei polmoni) o può essere la complicanza delle altre forme di tularemia (secondaria)
- forma oculo-ghiandolare, è poco frequente, si verifica quando l’agente patogeno raggiunge direttamente la congiuntiva dell’occhio. Coinvolge generalmente un solo occhio con sintomi che comprendono dolore, senso di fastidio provocato dalla luce (fotofobia) e aumento della lacrimazione. Alcuni pazienti possono presentare congiuntivite purulenta, piccole ulcere o noduli congiuntivali e arrossamento o rigonfiamento intorno all'occhio. Anche questa forma spesso si associa a linfadenopatia regionale
- forma orofaringea, generalmente fa seguito all’ingestione di cibo o acqua contaminati. Si manifesta con faringite e tonsillite, ingrossamento delle linfoghiandole cervicali e ulcere faringee o tonsillari particolarmente dolorose
- forma tifoidea, i sintomi possono essere quelli di una sepsi acuta o di una malattia febbrile cronica senza aumento di volume delle linfoghiandole o altre caratteristiche delle forme sopra riportate
La gravità della malattia dipende principalmente dallo stato immunitario del soggetto infettato e dalla quantità di germi inoculati. In generale il tipo A è molto aggressivo e può essere fulminante a differenza del tipo B che non causa forme letali se adeguatamente e prontamente trattate.
La letalità, nelle forme polmonari e tifoidee non trattate, può arrivare al 30%.
Cause
Il microrganismo responsabile, F. tularensis, è un bacillo aerobio di piccole dimensioni, pleiomorfo, immobile, non sporigeno e Gram-negativo che penetra nell’organismo tramite l’ingestione di cibo o acqua contaminati, morso di un vettore artropode infetto (zanzare, zecche, tafani, pulci), inalazione, contatto diretto con tessuti o materiale infetti.
Due tipi di F. tularensis causano la maggior parte dei casi di tularemia:
- tipo A, è il sierotipo più virulento per l'uomo; si ritrova generalmente nei conigli, nelle lepri e nei roditori negli Stati Uniti e in Canada
- tipo B, causa abitualmente un'infezione ulcero-ghiandolare lieve e si ritrova nei roditori e negli ambienti acquatici in tutto l'emisfero boreale, incluso il Nord America, l'Europa e l'Asia
Gli individui che solitamente contraggono l'infezione sono i cacciatori, i macellai, i contadini, e i conciatori di pelli. Non sono riportati casi di trasmissione da persona a persona.
Diagnosi
La diagnosi di tularemia viene fatta con la raccolta di una storia di contatti con conigli, lepri e roditori selvatici o esposizione ad artropodi (zanzare, zecche, tafani, pulci), dall'insorgenza improvvisa dei sintomi e dalla caratteristica lesione della pelle.
Per la conferma della diagnosi vengono utilizzati:
- esami colturali per la ricerca di F. tularensis, a seconda della presentazione clinica, i campioni possono essere rappresentati da sangue, da materiale proveniente dall'aspirazione o dalla biopsia delle linfoghiandole, dall'aspirazione della lesione cutanea, dal liquido pleurico, dall'espettorato o dai tamponi faringei
- test sierologici (ricerca nel sangue degli anticorpi contro il batterio), appaiono di solito a 2 settimane di distanza dall'inizio della malattia. Un aumento di 4 volte o un singolo titolo > 1:128 è diagnostico
- PCR (reazione a catena della polimerasi), fornisce una diagnosi rapida dimostrando il materiale genetico del batterio negli stessi campioni utilizzati per gli esami colturali
Terapia
La terapia antibiotica deve essere somministrata prontamente a tutti i pazienti con tularemia sospetta o confermata poiché un trattamento precoce ed efficace porta a una più rapida risoluzione della malattia e riduce le complicanze e talvolta la mortalità.
In età pediatrica gli antibiotici di scelta sono gli aminoglicosidi e i fluorochinolonici.
Bendaggi umidi di soluzione fisiologica applicati con continuità sono indicati per le lesioni cutanee primarie e possono attenuare la gravità della linfangite e della linfoadenite.
Nella tularemia oculare, si ottiene sollievo con applicazioni di garze imbevute di soluzione fisiologica calda e con l'uso di occhiali scuri. Nei casi più gravi, l'omatropina al 2% può alleviare i sintomi.
La cefalea intensa di solito risponde agli analgesici.
Prevenzione
Le misure preventive consistono principalmente nei comportamenti che minimizzano il rischio di esposizione al microbo, soprattutto in zone rurali.
È quindi opportuno, quando si entra in aree in cui F. tularensis è diffusa, indossare pantaloni lunghi e camice a maniche lunghe evitando di bere acqua non potabile.
In seguito a una possibile esposizione è necessario eseguire un'accurata ricerca delle zecche che, se presenti, devono essere rimosse immediatamente.
È inoltre essenziale una cottura adeguata delle carni selvatiche e la potabilizzazione delle acque potenzialmente contaminate.
Sebbene siano in corso delle ricerche sullo sviluppo di vaccini contro la tularemia, al momento non ne esistono di disponibili.
Complicazioni
I tassi di mortalità sono più alti per l'infezione di tipo A e per la tularemia tifoidea, setticemica e polmonare; sono al 30% per i casi non trattati. Il decesso si verifica in seguito ad infezione gravissima, polmonite, meningite o peritonite. Le recidive possono manifestarsi in soggetti trattati in maniera inadeguata. La prima infezione solitamente conferisce un'immunità completa.
Vivere con
Nei casi disseminati, si hanno le caratteristiche lesioni necrotiche focali in vari stadi di evoluzione, diffuse in tutto il corpo.
Nei casi di polmonite, i focolai necrotici si verificano a livello polmonare. Nonostante possa comparire una tossicità sistemica, finora non sono state scoperte tossine.
La tularemia è considerata un possibile agente di bioterrorismo perché l'inalazione di un minimo di 10 microrganismi sotto forma di aerosol può causare grave polmonite.
Link approfondimento
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Tularemia
Prossimo aggiornamento: 30 Dicembre 2026




























